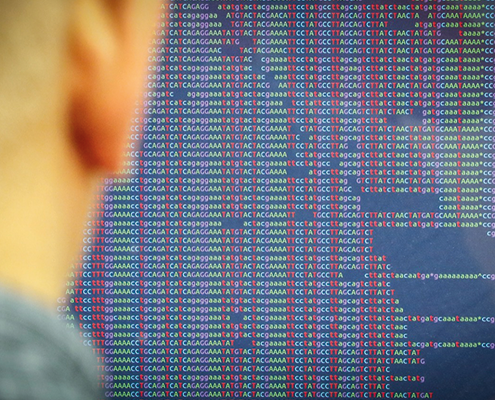Quanto hanno a che vedere i geni con il nostro carattere, le nostre scelte e i nostri gusti? A leggere i titoli dei giornali vi sarebbe una stretta correlazione e la scienza starebbe facendo passi da gigante per darci tutte le risposte. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto al prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, che, con il suo “Non nei nostri geni: Criminalità, Intelligenza, Origini”, interverrà alla terza conferenza della rassegna “Viaggio al centro della scienza”, in calendario mercoledì 16 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, su iniziativa dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP).
Quanto hanno a che vedere i geni con il nostro carattere, le nostre scelte e i nostri gusti? A leggere i titoli dei giornali vi sarebbe una stretta correlazione e la scienza starebbe facendo passi da gigante per darci tutte le risposte. Ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto al prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara, che, con il suo “Non nei nostri geni: Criminalità, Intelligenza, Origini”, interverrà alla terza conferenza della rassegna “Viaggio al centro della scienza”, in calendario mercoledì 16 maggio alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni, su iniziativa dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza e del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP).
Professor Barbujani, cosa sta a significare la negazione che apre il titolo della sua conferenza?
La negazione iniziale deriva dal fatto che in molti casi si sono lette sui giornali delle affermazioni infondate su quello che fanno i geni per determinare tante nostre caratteristiche complesse. Noi capiamo molto bene cosa fanno i geni uno alla volta ed è per questo che riusciamo a prevedere la distrofia muscolare di Duchenne, la fibrosi cistica, l’emofilia. Il diabete, invece, è un caso diverso: tanti geni, i fattori ambientali e la dieta possono determinarlo, di conseguenza non riusciamo a prevederlo. Ancora più complicati del diabete sono il cancro e le varie malattie cardio-circolatorie. Se consideriamo le nostre capacità cognitive, la nostra capacità di scegliere un comportamento piuttosto che un altro, allora lì entriamo in un campo davvero molto complesso, in cui è probabile che i geni abbiano un ruolo, ma nessuno l’ha ancora capito. Quindi la negazione iniziale vuole invitare ad andare cauti. I geni fanno tante cose che per la maggior parte non abbiamo ancora compreso.
Ad oggi quali informazioni fornisce il DNA?
Ci vengono date tantissime informazioni utili, per esempio stiamo cominciando a capire che persone con geni diversi devono ricevere anche un trattamento farmacologico diverso, e stiamo cominciando a prevedere come collegare i geni delle persone con i farmaci che prendono. Però siamo molto lontani dall’avere una comprensione dei fenomeni più complessi. Nel caso del cancro, sono pochissimi quelli che possiamo prevedere leggendo il DNA. Di recente ho scoperto un sevizio che propone di associarsi all’anima gemella in base al DNA: ci sono delle ipotesi, ma ci vorrà ancora del tempo per verificare se siano valide oppure no.
Da quanti fattori dipenderebbero i nostri comportamenti?
Possiamo dire quello che si poteva affermare cento anni fa, perché non siamo andati avanti. Dipendono da tanti fattori, in parte ereditari e in parte ambientali, che non conosciamo.
A livello comunicativo, da cosa deriva quest’ansia di abbinare un comportamento a un gene?
A mio avviso, si tratta di domande importanti che l’umanità si pone da sempre. Qualche tempo fa leggevo di Erodoto che era stato sul campo della battaglia di Pelusio, dove persiani ed egiziani si erano combattuti. Erodoto, ad un certo punto, vedendo i cadaveri si chiede come mai apparentemente i crani dei secondi fossero più resistenti di quelli dei primi. Formulò allora l’ipotesi che gli egiziani, radendosi la testa, esponessero il cranio ai raggi solari e ciò lo rinforzasse. È una spiegazione sbagliata. La rasatura del cranio non c’entra nulla, ma dimostra come sin dai tempi dell’antichità classica sorgessero certe domande. In maniera analoga, è perfettamente logico che oggi ci chiediamo come mai alcuni individui riescano a fare bene i test matematici e altri invece vi si scontrino. Il problema è che non abbiamo capito le basi genetiche di questi fenomeni, ma, d’altra parte, quando un giornalista deve scrivere un articolo scientifico su di essi, non dice “abbiamo capito il 3% del problema”. In tal modo si attiva un meccanismo per cui, da un lato, i lettori si aspettano sempre di più e, dall’altro, i giornalisti cercano di assecondarli, perdendo di vista la complessità dei fenomeni allo studio.
Come genetisti, in che modo affrontate il problema?
È complicato. Ci sono anche delle nostre responsabilità. È chiaro che riceviamo dei finanziamenti, a volte anche molto generosi, per fare delle ricerche e poi si tende a gonfiare i propri dati. In qualche modo stimoliamo questo atteggiamento e i giornalisti sono molto ricettivi perché vogliono fare i titoloni. Si finisce così per “drogare” l’opinione pubblica. Per fare un esempio facile da verificare, se si scrive su Google “gene dell’intelligenza”, si troveranno, a partire dagli anni Novanta, una serie di articoli sulla scoperta di questo gene. Ebbene, se se ne parla nel 1998, perché poi è stato scoperto anche nel 2000, 2006, 2012 e così via? Evidentemente non si tratta dei geni dell’intelligenza, ma di geni che, in determinate condizioni, possono permettere certe prestazioni positive un po’ meglio o un po’ peggio degli altri. Poiché nel nostro cervello si esprimono circa 15mila dei nostri 22mila geni, è evidente quanto sia difficile capire le loro possibili interazioni, ma anche quanto pesino l’istruzione, la classe sociale, le scuole e le compagnie che abbiamo frequentato. Sono domande interessanti, ma le risposte non le abbiamo.
Qual è lo stato attuale della ricerca?
Personalmente mi sto occupando di altre cose proprio perché queste sono così complicate che ho deciso di lasciarle stare. Da cittadino consapevole, però, mi rendo conto che molto spesso le notizie sono pompate. In realtà soffriamo ancora dell’eredità di Mendel, che ci ha insegnato a studiare gli effetti dei geni uno alla volta (di qui la genetica). Adesso si sono sviluppati i metodi della genomica che permettono di leggere tutto il DNA. Il punto è che, una volta che l’abbiamo letto, ci troviamo nelle condizioni di una persona che ha di fronte un testo in lingua straniera e si aiuta solo con il dizionario. Come a dire che capiamo le singole parole, ma non il senso complessivo del discorso.
Lei sostiene che cercare assolutamente “il” gene può produrre disastri sociali. Ci può fare un esempio storico?
Sì, emblematico è quello dei cosiddetti “geni della criminalità”. Negli anni Sessanta si era diffusa la notizia, infondata, che chi aveva due cromosomi Y (normalmente i maschi della nostra specie ne hanno uno) era portato alla criminalità. Ciò derivava da uno studio scozzese sui detenuti del manicomio criminale, che però era stato condotto male. Oggi sappiamo che può esistere un gene della criminalità che ha a che vedere con le tradizioni culturali e con le leggi di un popolo. Tuttavia, fino a quando questa teoria del doppio cromosoma Y non è stata screditata, negli Stati Uniti d’America i ragazzi del riformatorio che avevano un cromosoma Y in più furono castrati chimicamente.
Guido Barbujani è nato nel 1955. Ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook, alle Università di Londra, Padova e Bologna, e attualmente è professore di Genetica all’Università di Ferrara. Nel 2014 ha vinto il Premio Napoli per la lingua e la cultura italiana, collabora al Sole 24 Ore. Fra i suoi libri, L’invenzione delle razze (Bompiani 2006), Europei senza se e senza ma (Bompiani 2008), Sono razzista, ma sto cercando di smettere (con Pietro Cheli, Laterza 2008), Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e di scienziati (Einaudi 2014), Contro il razzismo (con Marco Aime, Federico Faloppa e Clelia Bartoli, Einaudi 2016), Gli africani siamo noi (Laterza 2016), Il gene riluttante (con Lisa Vozza, Zanichelli 2017) e Il giro del mondo in sei milioni di anni (con Andrea Brunelli, Il Mulino, 2018).